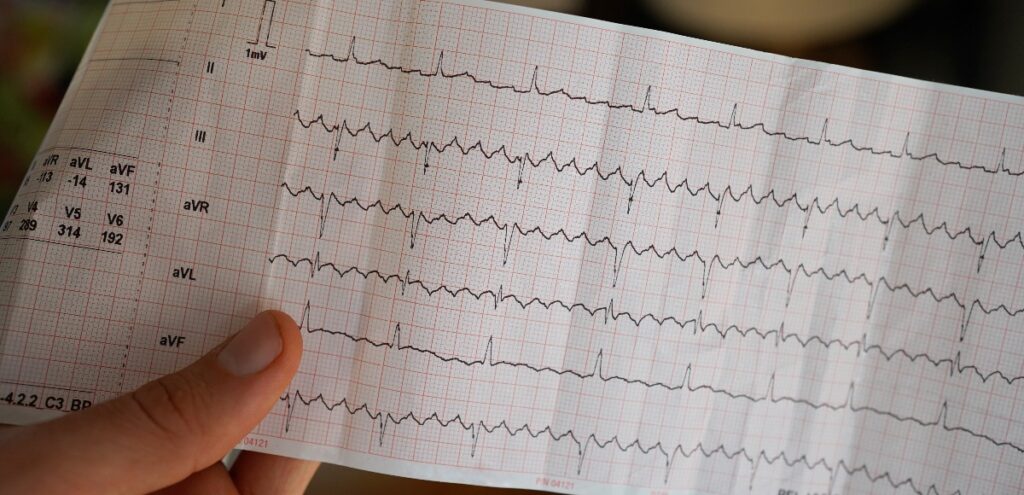La peritonite: quando può essere fatale
La peritonite rappresenta una delle emergenze mediche più gravi che possono verificarsi nell’addome. Questa infiammazione acuta del peritoneo, la membrana che riveste la cavità addominale e gli organi interni, può trasformarsi rapidamente in una condizione potenzialmente mortale se non riconosciuta e trattata tempestivamente. Comprendere i meccanismi, i sintomi e i fattori di rischio di questa patologia è fondamentale per riconoscere quando è necessario un intervento medico urgente.
Cos’è la peritonite
La peritonite è un processo infiammatorio, solitamente di origine infettiva, che colpisce il peritoneo. Questa sottile membrana sierosa riveste internamente la parete addominale e avvolge la maggior parte degli organi contenuti nella cavità peritoneale, creando un ambiente normalmente sterile e lubrificato.
Quando batteri, funghi o altre sostanze irritanti penetrano in questo spazio normalmente protetto, scatenano una risposta infiammatoria intensa. Il peritoneo reagisce producendo liquido infiammatorio che può accumularsi nella cavità addominale, compromettendo il normale funzionamento degli organi interni.
La gravità della peritonite dipende dall’estensione dell’infezione, dal tipo di microrganismo coinvolto e dalla rapidità con cui viene instaurato il trattamento appropriato. Nelle forme più severe, l’infezione può diffondersi rapidamente, causando sepsi e shock settico.
Cause principali della peritonite
Le cause della peritonite sono molteplici e possono essere classificate in primarie e secondarie. La peritonite primaria, più rara, si verifica quando i batteri raggiungono il peritoneo attraverso il flusso sanguigno o linfatico, senza una fonte evidente di infezione addominale.
La peritonite secondaria, molto più comune, deriva dalla perforazione o dalla rottura di un organo addominale. L’appendicite rappresenta una delle cause più frequenti: quando l’appendice si perfora, il contenuto intestinale ricco di batteri si riversa nella cavità peritoneale, scatenando un’infezione grave.
La perforazione di un’ulcera peptica può causare il versamento di succo gastrico acido e batteri nella cavità addominale. Anche la diverticolite complicata, con perforazione di diverticoli intestinali, rappresenta una causa significativa di peritonite.
Le procedure chirurgiche addominali, seppur rare, possono occasionalmente causare peritonite se si verificano complicanze come deiscenza di anastomosi o contaminazione durante l’intervento. I traumi addominali penetranti possono danneggiare organi interni, causando spillage di contenuto intestinale nel peritoneo.
Altre cause includono la malattia infiammatoria pelvica nelle donne, in cui l’infezione può estendersi dalle tube di Falloppio al peritoneo, e la dialisi peritoneale, che può occasionalmente introdurre batteri nella cavità addominale.
Sintomi della peritonite
I sintomi della peritonite si sviluppano tipicamente in modo rapido e progressivo, riflettendo la gravità del processo infiammatorio in corso. Il dolore addominale rappresenta il sintomo cardine, caratterizzato da intensità severa e diffusione progressiva a tutto l’addome.
Inizialmente, il dolore può essere localizzato nella zona dell’organo interessato – per esempio, nella fossa iliaca destra in caso di appendicite perforata – ma tende rapidamente a diventare generalizzato. Il paziente tipicamente assume una posizione antalgica, con ginocchia flesse verso il petto per ridurre la tensione sulla parete addominale.
La rigidità addominale, nota come “addome a tavola”, è un segno caratteristico che riflette la contrazione riflessa dei muscoli addominali per proteggere gli organi infiammati sottostanti. Anche il più leggero tocco può scatenare dolore intenso.
La febbre è presente nella maggior parte dei casi, spesso elevata e accompagnata da brividi. La temperatura può raggiungere valori molto alti, indicando la gravità del processo infettivo in corso.
I sintomi gastrointestinali includono nausea e vomito persistenti, che inizialmente possono essere riflessi ma successivamente diventano meccanici a causa dell’ileo paralitico. La cessazione completa dell’emissione di gas e feci indica l’arresto della peristalsi intestinale.
Nei casi più avanzati, possono svilupparsi segni di shock settico: tachicardia, ipotensione, alterazione dello stato di coscienza, cute fredda e sudata. Questi sintomi indicano una compromissione sistemica grave che richiede intervento medico immediato.
Quando la peritonite diventa fatale
La peritonite può evolvere verso esiti fatali attraverso diversi meccanismi fisiopatologici interconnessi. La progressione verso la sepsi rappresenta la complicanza più temibile: l’infezione locale si generalizza, causando una risposta infiammatoria sistemica che compromette la funzionalità di organi vitali.
Il sequestro di liquidi nella cavità addominale può causare grave ipovolemia e shock ipovolemico. L’infiammazione intensa aumenta la permeabilità dei vasi sanguigni, causando perdita massiva di plasma nello spazio extravasale e riducendo drasticamente il volume circolante efficace.
L’insufficienza multiorgano rappresenta la fase terminale del processo settico. I reni possono cessare di funzionare a causa dell’ipoperfusione, mentre il fegato può essere compromesso dalle tossine batteriche. La compromissione polmonare può svilupparsi come parte della sindrome da distress respiratorio acuto.
La formazione di ascessi multipli e l’evoluzione verso una peritonite cronica possono rendere il trattamento estremamente complesso, richiedendo interventi chirurgici ripetuti e prolungati cicli di antibiotici.
Il timing dell’intervento medico è cruciale: ogni ora di ritardo nel trattamento aumenta significativamente il rischio di mortalità. Studi clinici dimostrano che la mortalità può aumentare dal 10% nelle prime ore fino al 40-60% se il trattamento viene ritardato oltre le 24-48 ore.
Peritonite pelvica: caratteristiche specifiche
La peritonite pelvica rappresenta una forma particolare che colpisce principalmente le donne in età fertile. Questa condizione è spesso conseguenza di malattia infiammatoria pelvica (PID), in cui l’infezione inizia negli organi riproduttivi femminili e si estende al peritoneo pelvico.
I microrganismi responsabili includono principalmente Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae e batteri anaerobi. L’infezione può propagarsi dalle tube di Falloppio, creando ascessi tubo-ovarici che possono successivamente rompersi e causare peritonite generalizzata.
I sintomi della peritonite pelvica possono essere più subdoli rispetto alla forma generalizzata, con dolore pelvico, febbre, perdite vaginali anomale e dolore durante i rapporti sessuali. Il ritardo diagnostico è più frequente, aumentando il rischio di complicanze a lungo termine come infertilità e dolore pelvico cronico.
Diagnosi della peritonite
La diagnosi di peritonite richiede un approccio clinico urgente basato sulla valutazione dei sintomi, dell’esame obiettivo e di specifici esami diagnostici. L’esame fisico rivela segni caratteristici come la dolorabilità di rimbalzo, la rigidità addominale e l’assenza di rumori intestinali.
Gli esami di laboratorio mostrano tipicamente leucocitosi marcata con shift a sinistra, aumento degli indici di flogosi (PCR, procalcitonina) e possibili alterazioni degli equilibri elettrolitici e acido-base. L’emocromo può rivelare anemia e piastrinopenia nelle forme più gravi.
La diagnostica per immagini gioca un ruolo fondamentale. La TC addominale con contrasto rappresenta l’esame di scelta, permettendo di identificare la causa sottostante, valutare l’estensione dell’infezione e guidare l’approccio terapeutico. L’ecografia addominale può essere utile per identificare raccolte liquide.
La paracentesi diagnostica, quando indicata, può fornire informazioni preziose attraverso l’analisi del liquido peritoneale, permettendo l’identificazione del microrganismo responsabile e la definizione dell’antibiogramma.
Trattamento della peritonite
Il trattamento della peritonite richiede un approccio multidisciplinare urgente che combina terapia medica e, nella maggior parte dei casi, intervento chirurgico. La terapia antibiotica deve essere iniziata immediatamente, anche prima della conferma microbiologica, utilizzando schemi ad ampio spettro che coprano batteri gram-positivi, gram-negativi e anaerobi.
La scelta antibiotica iniziale spesso include combinazioni come piperacillina-tazobactam, meropenem o combinazioni di fluorochinoloni con metronidazolo. L’antibiogramma del liquido peritoneale permetterà successivamente di ottimizzare la terapia.
L’intervento chirurgico è necessario nella maggior parte dei casi per eliminare la fonte dell’infezione, rimuovere materiale infetto e necrotico, e lavare abbondantemente la cavità peritoneale. La tecnica chirurgica dipende dalla causa sottostante: appendicectomia per appendicite perforata, sutura di perforazione peptica, resezione intestinale per diverticolite complicata.
Il supporto delle funzioni vitali è fondamentale: rianimazione con fluidi per correggere l’ipovolemia, supporto vasopressorio se necessario, correzione degli squilibri elettrolitici e acido-base. Nei casi più gravi può essere necessario il supporto di terapia intensiva con ventilazione meccanica e dialisi.
Prevenzione e prognosi
La prevenzione della peritonite si basa principalmente sul riconoscimento e trattamento tempestivo delle condizioni che possono evolvere verso la perforazione. L’appendicite, la diverticolite e l’ulcera peptica devono essere diagnosticate e trattate prima che si sviluppino complicanze.
La prognosi dipende da molteplici fattori: età del paziente, estensione dell’infezione, presenza di comorbidità, tempestività del trattamento e tipo di microrganismo coinvolto. Nei pazienti giovani e sani, trattati precocemente, la mortalità può essere inferiore al 5%, mentre negli anziani con multiple comorbidità e trattamento ritardato può superare il 50%.
Le complicanze a lungo termine possono includere aderenze intestinali con rischio di occlusione, formazione di ascessi ricorrenti e, nelle donne, infertilità secondaria a danno tubarico. In caso di persistenti disturbi addominali dopo un episodio di peritonite, può essere necessaria una colonscopia di controllo per escludere complicanze a lungo termine, specialmente quando si associa mal di stomaco persistente.