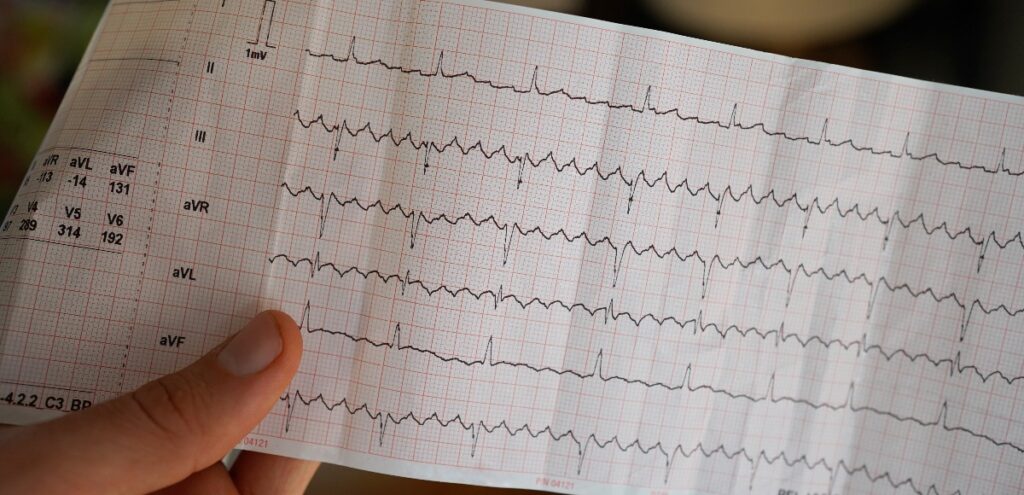Le placche in gola: cosa sono e quali le cause
Le placche in gola rappresentano un sintomo allarmante che spesso preoccupa chi ne soffre. Queste formazioni biancastre o giallastre visibili sulle tonsille o sulla parete posteriore della faringe sono tipicamente associate a infezioni batteriche o virali e si accompagnano a mal di gola, difficoltà nella deglutizione e febbre.
Comprendere cosa sono le placche, quali patologie possono causarle e quando è necessario consultare un medico è fondamentale per affrontare correttamente questo disturbo e prevenire eventuali complicanze.
Cosa sono le placche in gola
Le placche in gola sono depositi di materiale biancastro, giallastro o grigiastro che si formano sulla superficie delle tonsille palatine o sulla mucosa della faringe. Questi depositi sono costituiti da una combinazione di cellule morte della mucosa, globuli bianchi, batteri o virus, detriti cellulari e proteine del sistema immunitario.
Le placche si formano come risposta del sistema immunitario a un’infezione. Quando agenti patogeni invadono la mucosa faringea o tonsillare, il corpo invia globuli bianchi per combattere l’infezione. L’accumulo di questi globuli, insieme a cellule morte e detriti, forma le caratteristiche placche visibili a occhio nudo.
Le tonsille palatine, due masse di tessuto linfoide situate ai lati della gola, sono particolarmente soggette alla formazione di placche. La loro superficie irregolare, con numerose cripte e invaginazioni, facilita l’accumulo di materiale e la crescita batterica. Le tonsille svolgono una funzione importante nel sistema immunitario, particolarmente nei bambini, catturando e combattendo patogeni che entrano attraverso bocca e naso.
L’aspetto delle placche può variare: possono essere piccole chiazze puntiformi, depositi più estesi che ricoprono ampie aree tonsillari, o membrane più spesse che aderiscono tenacemente alla superficie. Il colore può variare dal bianco al giallo intenso o al grigio, a seconda della causa sottostante e della fase dell’infezione.
Cause delle placche in gola
Le cause delle placche in gola sono molteplici, con le infezioni che rappresentano l’eziologia più comune. La faringotonsillite streptococcica, causata dallo Streptococcus pyogenes (streptococco beta-emolitico di gruppo A), è la causa batterica più frequente. Questa infezione colpisce principalmente bambini e adolescenti tra 5 e 15 anni, presentandosi con placche purulente sulle tonsille, febbre elevata e dolore intenso alla deglutizione.
Lo streptococco richiede sempre trattamento antibiotico per prevenire complicanze gravi come febbre reumatica acuta, che può danneggiare le valvole cardiache, e glomerulonefrite post-streptococcica, che colpisce i reni. La scarlattina, una complicanza della faringite streptococcica, si manifesta con un’eruzione cutanea caratteristica oltre ai sintomi faringei.
La mononucleosi infettiva, causata dal virus di Epstein-Barr, è una causa virale importante di placche in gola. Questa infezione, nota anche come “malattia del bacio”, si trasmette attraverso la saliva e colpisce prevalentemente adolescenti e giovani adulti. Si caratterizza per placche estese e grigiastre sulle tonsille, gonfiore tonsillare marcato che può quasi occludere la faringe, linfonodi ingrossati diffusi e splenomegalia.
Altri virus possono causare placche, inclusi adenovirus, che causano faringite essudativa con febbre alta, e virus herpes simplex, particolarmente di tipo 1, che può causare gengivostomatite erpetica con vescicole e ulcere dolorose in bocca e gola. Il virus Coxsackie causa la malattia mano-piede-bocca con vescicole faringee.
Infezioni fungine, principalmente da Candida albicans, causano mughetto orale che può estendersi alla faringe. Si manifesta con placche biancastre cremose facilmente rimovibili, lasciando una superficie arrossata e sanguinante. Questa condizione è più comune in neonati, anziani, pazienti diabetici, immunodepressi o dopo terapia antibiotica prolungata.
La difterite, causata da Corynebacterium diphtheriae, è oggi rara nei paesi con adeguata copertura vaccinale, ma resta endemica in alcune regioni. Si caratterizza per membrane grigiastre aderenti che, se rimosse, lasciano una superficie sanguinante. Può causare ostruzione respiratoria e gravi complicanze sistemiche per la produzione di una potente tossina.
Sintomi associati alle placche in gola
Le placche in gola raramente si presentano isolate e sono generalmente accompagnate da una costellazione di sintomi che variano in base alla causa sottostante. Il dolore faringeo rappresenta il sintomo più costante, descritto come sensazione di bruciore, pizzicore o dolore lancinante che si intensifica drammaticamente durante la deglutizione.
La difficoltà a deglutire, sia solidi che liquidi, può essere così pronunciata che alcuni pazienti, specialmente bambini, rifiutano di mangiare e bere, con rischio di disidratazione. Il dolore può irradiarsi alle orecchie per la vicinanza anatomica e l’innervazione comune.
La febbre è tipicamente presente nelle infezioni batteriche, specialmente nella faringite streptococcica dove può raggiungere 39-40°C. Nella mononucleosi la febbre può persistere per 1-2 settimane, mentre nelle infezioni virali comuni tende ad essere più moderata e di breve durata.
L’ingrossamento dei linfonodi del collo è un segno caratteristico. I linfonodi laterocervicali anteriori e sottomandibolari diventano palpabili, aumentati di volume e dolenti alla palpazione. Nella mononucleosi, i linfonodi possono essere molto ingrossati e coinvolgere multiple stazioni linfonodali, incluse quelle ascellari e inguinali.
L’alitosi (alito cattivo) accompagna frequentemente le placche per la presenza di materiale purulento e batteri. L’odore può essere particolarmente sgradevole nelle infezioni anaerobie. La voce può diventare nasale per il gonfiore tonsillare che modifica la risonanza della faringe.
Il malessere generale, l’astenia marcata e i dolori muscolari diffusi sono prominenti nella mononucleosi e nell’influenza. I pazienti descrivono una stanchezza profonda che può persistere per settimane o mesi dopo la risoluzione dei sintomi acuti, specialmente nella mononucleosi.
Differenza tra placche batteriche e virali
Distinguere clinicamente tra placche di origine batterica e virale è importante ma non sempre facile, poiché esiste sovrapposizione significativa nelle manifestazioni. Tuttavia, alcune caratteristiche possono orientare la diagnosi.
Le placche streptococciche tendono ad essere di colore bianco-giallastro, ben delimitate e distribuite a chiazze sulla superficie tonsillare. Le tonsille appaiono molto arrossate e gonfie, e possono essere presenti petecchie sul palato molle. L’esordio è tipicamente acuto con febbre alta improvvisa e dolore severo. I sintomi di raffreddore come tosse, rinorrea e congestione nasale sono tipicamente assenti.
Le placche virali, particolarmente nella mononucleosi, tendono ad essere più estese, di colore grigiastro, e possono ricoprire quasi completamente le tonsille creando un aspetto a “pseudomembrana”. Il gonfiore tonsillare può essere così marcato da causare quasi occlusione della faringe. I sintomi si sviluppano più gradualmente e l’astenia è particolarmente pronunciata.
Nella candidosi orale, le placche sono bianche, cremose e facilmente rimovibili con una spatola, lasciando una superficie arrossata e talvolta sanguinante. Non sono limitate alle tonsille ma possono coinvolgere lingua, palato e mucose buccali. Il dolore è generalmente meno intenso rispetto alle infezioni batteriche.
I criteri clinici, pur utili, non sono sufficientemente accurati per una diagnosi definitiva. Il test rapido per streptococco (rapid antigen detection test) permette una diagnosi rapida in ambulatorio con risultati in 5-10 minuti. Ha alta specificità ma sensibilità variabile, quindi un test negativo in presenza di forte sospetto clinico dovrebbe essere confermato con coltura faringea.
Diagnosi delle placche in gola
La diagnosi delle placche in gola inizia con un’accurata anamnesi e un esame obiettivo. Il medico indaga sull’esordio dei sintomi, sulla presenza di febbre, sul contatto con persone malate, su eventuali viaggi recenti e sullo stato vaccinale.
L’esame della gola con l’ausilio di una fonte luminosa e di un abbassalingua permette di visualizzare direttamente le placche, valutandone estensione, colore, distribuzione e facilità di rimozione. Si osservano anche il grado di arrossamento e gonfiore delle tonsille e della faringe, la presenza di petecchie palatine, e segni di disidratazione della mucosa.
La palpazione dei linfonodi del collo valuta dimensioni, consistenza, dolorabilità e mobilità. Linfonodi molto ingrossati e dolenti suggeriscono infezione acuta, mentre linfonodi duri e fissi richiedono ulteriori approfondimenti per escludere patologie più serie.
Il tampone faringeo rappresenta l’esame diagnostico principale. Il campione viene prelevato strofinando un tampone sterile sulla superficie delle tonsille e della parete posteriore della faringe, evitando di toccare lingua e guance per non contaminare il campione. Il materiale può essere analizzato con test rapido per streptococco o inviato per coltura batterica.
La coltura faringea è il gold standard per la diagnosi di faringite streptococcica, con sensibilità superiore al test rapido. Richiede 24-48 ore per i risultati e permette anche l’esecuzione dell’antibiogramma per guidare la terapia in caso di resistenze antibiotiche.
Gli esami del sangue possono essere utili in casi selezionati. L’emocromo può mostrare leucocitosi con predominanza di neutrofili nelle infezioni batteriche, o linfocitosi con linfociti atipici nella mononucleosi. Il test per gli anticorpi eterofili (monotest) o gli anticorpi specifici per EBV confermano la diagnosi di mononucleosi.
Cosa fare in caso di placche in gola
Il comportamento da adottare in presenza di placche in gola dipende dalla severità dei sintomi e dalla causa sospetta. In attesa di valutazione medica, alcune misure possono alleviare il disagio e supportare la guarigione.
L’idratazione abbondante è fondamentale per mantenere umide le mucose e facilitare la deglutizione. Liquidi freschi o tiepidi sono generalmente meglio tollerati di quelli molto caldi o freddi. Brodi, tisane, succhi di frutta non acidi e acqua dovrebbero essere consumati regolarmente in piccole quantità.
Gli analgesici e antipiretici come paracetamolo o ibuprofene controllano dolore e febbre. L’ibuprofene ha il vantaggio di un’azione antinfiammatoria che può ridurre il gonfiore faringeo. Le dosi devono essere appropriate per età e peso, e l’aspirina deve essere evitata nei bambini per il rischio di sindrome di Reye.
I gargarismi con acqua salata tiepida più volte al giorno possono ridurre il dolore e rimuovere parzialmente le placche superficiali. La soluzione si prepara sciogliendo mezzo cucchiaino di sale in un bicchiere d’acqua tiepida. Anche gargarismi con acqua e bicarbonato possono essere utili.
Il riposo è importante per permettere al sistema immunitario di combattere l’infezione efficacemente. Evitare sforzi fisici e garantire sonno adeguato favorisce la guarigione. I bambini dovrebbero rimanere a casa da scuola sia per riposare che per evitare il contagio.
Alimenti morbidi e facili da deglutire riducono il dolore durante i pasti: yogurt, gelati, frullati, purea di patate, minestre e budini sono generalmente ben tollerati. Evitare cibi duri, croccanti, piccanti o acidi che possono irritare ulteriormente la gola.
L’umidificazione dell’ambiente riduce l’irritazione da aria secca. Evitare fumo di sigaretta e altri irritanti è fondamentale, poiché danneggiano le mucose e rallentano la guarigione.
Trattamento delle placche in gola
Il trattamento delle placche in gola varia significativamente in base alla causa identificata. La faringotonsillite streptococcica richiede sempre terapia antibiotica per eradicare l’infezione e prevenire complicanze. La penicillina o amoxicillina rappresentano gli antibiotici di prima scelta, somministrati per 10 giorni.
Per pazienti allergici alla penicillina, si utilizzano macrolidi come azitromicina o claritromicina, o cefalosporine di prima generazione. È fondamentale completare l’intero ciclo antibiotico anche se i sintomi migliorano prima, per prevenire recidive e complicanze.
Il miglioramento clinico con antibiotici appropriati è rapido: febbre e dolore diminuiscono tipicamente entro 24-48 ore dall’inizio del trattamento. Tuttavia, il paziente rimane contagioso per le prime 24 ore di terapia, quindi dovrebbe evitare contatti ravvicinati con altri.
Le infezioni virali come la mononucleosi non beneficiano di antibiotici e il trattamento è esclusivamente sintomatico. Il riposo è particolarmente importante, data l’astenia pronunciata. L’attività fisica intensa deve essere evitata per almeno 3-4 settimane per il rischio di rottura splenica in caso di splenomegalia.
I corticosteroidi possono essere utilizzati nella mononucleosi severa con marcato gonfiore tonsillare che minaccia l’ostruzione delle vie aeree, o in presenza di complicanze specifiche. Il loro uso deve essere valutato attentamente da un medico.
La candidosi orale richiede terapia antifungina con antimicotici topici come nistatina sospensione o miconazolo gel per forme lievi, o fluconazolo orale per forme più estese o ricorrenti. È importante trattare anche eventuali fattori predisponenti come diabete non controllato o uso di corticosteroidi inalatori.
In casi selezionati di tonsilliti ricorrenti severe, può essere considerata la tonsillectomia. Le indicazioni includono più di 7 episodi nell’ultimo anno, più di 5 episodi all’anno per due anni consecutivi, o più di 3 episodi all’anno per tre anni consecutivi, con compromissione significativa della qualità di vita.
Quando consultare il medico
La presenza di placche in gola richiede generalmente valutazione medica per identificare la causa e stabilire il trattamento appropriato. È particolarmente importante consultare tempestivamente il medico in presenza di sintomi severi o di peggioramento progressivo.
Indicazioni per consultazione urgente includono:
- febbre molto elevata (>39°C) che non risponde agli antipiretici
- dolore intenso che impedisce la deglutizione di liquidi
- difficoltà respiratoria o sensazione di soffocamento
- rigidità nucale associata a forte cefalea
L’impossibilità di aprire completamente la bocca (trisma) può indicare un ascesso peritonsillare, una complicanza che richiede intervento urgente. Anche la presenza di tumefazione asimmetrica della gola o del collo, o deviazione dell’ugola da un lato, suggeriscono questa complicanza.
Segni di disidratazione come riduzione marcata della diuresi, vertigini, confusione mentale, mucose molto secche e assenza di lacrime nei bambini richiedono attenzione immediata, specialmente nei bambini piccoli e negli anziani.
Nei bambini, particolare attenzione va prestata a irritabilità inconsolabile, letargia marcata, rifiuto completo di bere, respiro affannoso o rumoroso, e salivazione eccessiva con incapacità di deglutire, che possono indicare complicanze gravi.
Anche in assenza di sintomi di allarme, è opportuno consultare il medico se le placche persistono oltre 3-4 giorni, se la febbre dura più di 3 giorni, o se compaiono nuovi sintomi come eruzioni cutanee, dolore addominale, sangue nell’espettorato, o ingrossamento progressivo dei linfonodi.
Prevenzione delle placche in gola
La prevenzione delle placche in gola si focalizza sulla riduzione del rischio di infezioni respiratorie e sul mantenimento di buone condizioni di salute generale. L’igiene delle mani rappresenta la misura preventiva più efficace: lavarle frequentemente con acqua e sapone per almeno 20 secondi, specialmente dopo contatti con persone malate, prima di mangiare e dopo aver tossito o starnutito.
Evitare la condivisione di oggetti personali come bicchieri, posate, bottiglie, asciugamani o spazzolini da denti previene la trasmissione di patogeni. Anche evitare contatti ravvicinati come baci con persone che presentano sintomi di infezione respiratoria riduce significativamente il rischio di contagio.
Coprire bocca e naso con un fazzoletto o con il gomito quando si tossisce o starnutisce, e smaltire immediatamente i fazzoletti usati, limita la dispersione di droplet infette nell’ambiente. Questi gesti sono particolarmente importanti per chi è già malato per proteggere gli altri.
Il rafforzamento del sistema immunitario attraverso uno stile di vita sano supporta le difese naturali dell’organismo. Un’alimentazione equilibrata ricca di frutta e verdura fornisce vitamine e antiossidanti essenziali. Un sonno adeguato e regolare, attività fisica moderata e gestione dello stress contribuiscono a mantenere efficiente la risposta immunitaria.
La vaccinazione antinfluenzale riduce il rischio di complicanze influenzali, incluse sovrainfezioni batteriche che possono causare placche. È particolarmente raccomandata per bambini, anziani, donne in gravidanza e persone con patologie croniche.
Evitare il fumo di sigaretta e l’esposizione al fumo passivo è fondamentale: il fumo danneggia le mucose respiratorie, compromette i meccanismi di difesa locali e aumenta la suscettibilità alle infezioni. Anche limitare l’esposizione ad altri irritanti come inquinanti atmosferici e sostanze chimiche protegge le vie respiratorie.