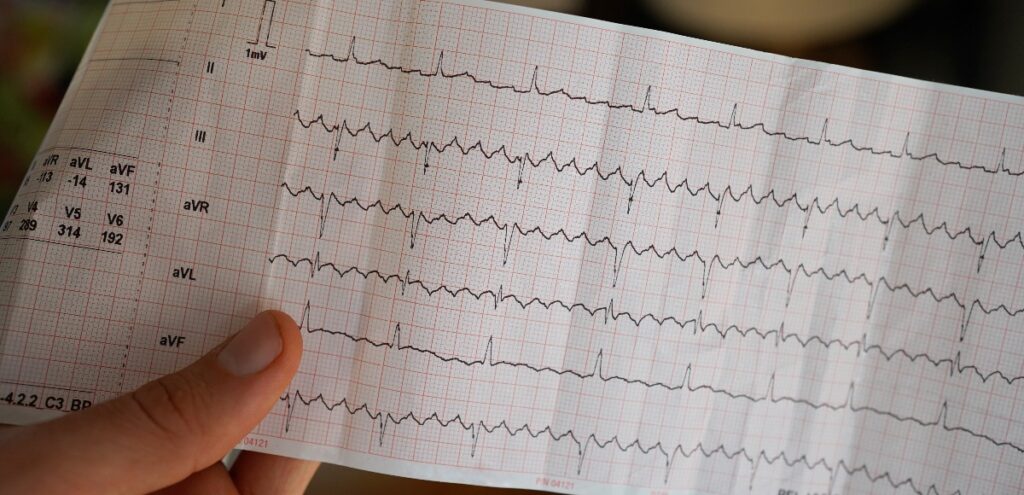La gola arrossata: come capire se si ha la gola rossa
Il termine gola arrossata viene utilizzato per rappresentare uno dei disturbi più comuni che spingono le persone a consultare il medico, specialmente durante i mesi freddi.
Questo sintomo, tecnicamente chiamato faringite o faringodinia, indica un’infiammazione della mucosa faringea che può avere diverse cause, dalle infezioni virali a quelle batteriche, fino a fattori irritativi non infettivi. Riconoscere la gola arrossata e comprenderne le cause è importante per stabilire se è necessario un intervento medico o se il disturbo può essere gestito con rimedi sintomatici.
Cos’è la gola arrossata
La gola arrossata è una manifestazione visibile dell’infiammazione della faringe, il canale muscolo-membranoso che collega la cavità nasale e orale all’esofago e alla laringe. L’arrossamento deriva dall’aumento del flusso sanguigno nella zona infiammata, un meccanismo difensivo dell’organismo che porta più cellule immunitarie e nutrienti nel sito dell’infiammazione.
Anatomicamente, la faringe si divide in tre parti: rinofaringe (dietro il naso), orofaringe (dietro la bocca) e ipofaringe (vicino alla laringe). L’infiammazione può interessare una o più di queste sezioni, con manifestazioni cliniche leggermente diverse.
La mucosa faringea normale appare di colore rosato, umida e liscia. Quando si infiamma, diventa rosso intenso o rosso vivo, può presentare gonfiore, essudato o piccole vescicole. Le tonsille palatine, quando presenti, possono apparire ingrossate e arrossate, talvolta con depositi biancastri o giallastri sulla superficie.
L’infiammazione attiva recettori del dolore presenti nella mucosa, causando la sensazione di bruciore, pizzicore o dolore che caratterizza il mal di gola. La deglutizione diventa dolorosa perché il movimento muscolare stimola ulteriormente le terminazioni nervose sensibilizzate.
Cause della gola arrossata
Le cause della gola arrossata sono molteplici e possono essere classificate in infettive e non infettive. Le infezioni virali rappresentano la causa più frequente, responsabili di circa il 70-85% dei casi di faringite acuta. I virus più comunemente coinvolti includono rinovirus, coronavirus, adenovirus, virus influenzali e parainfluenzali.
Il virus di Epstein-Barr, responsabile della mononucleosi infettiva, causa faringite severa con marcato arrossamento e gonfiore tonsillare, spesso accompagnata da linfonodi ingrossati e splenomegalia. Anche i virus herpes simplex possono causare faringite, particolarmente nei bambini piccoli.
Le infezioni batteriche sono meno comuni ma potenzialmente più gravi. Lo Streptococcus pyogenes (streptococco beta-emolitico di gruppo A) è il batterio più importante, responsabile della faringotonsillite streptococcica che colpisce principalmente bambini tra 5 e 15 anni. Questa infezione richiede trattamento antibiotico per prevenire complicanze come la febbre reumatica.
Altri batteri possono causare faringite, inclusi Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae e, più raramente, Neisseria gonorrhoeae (in caso di contatto orofaringeo). La difterite, causata da Corynebacterium diphtheriae, è ormai rara nei paesi con adeguata copertura vaccinale.
Fattori irritativi non infettivi includono il fumo di sigaretta, l’esposizione a inquinanti atmosferici, l’aria secca e climatizzata, il reflusso gastroesofageo e lo sforzo vocale eccessivo. Anche allergie stagionali possono causare irritazione faringea con arrossamento.
Come riconoscere la gola arrossata
Riconoscere la gola arrossata richiede sia l’osservazione diretta che l’attenzione ai sintomi associati. L’autoesame può essere effettuato utilizzando una fonte di luce (come la torcia dello smartphone) e uno specchio, chiedendo alla persona di aprire bene la bocca e dire “aaaah” per abbassare la lingua.
Normalmente, la gola appare rosata con tonalità uniformi. La presenza di arrossamento si manifesta con una colorazione più intensa, che può variare dal rosso chiaro al rosso vivo. L’arrossamento può essere diffuso su tutta la parete posteriore della faringe o più localizzato.
Le tonsille, quando presenti e visibili ai lati della gola, possono apparire gonfie e arrossate. La presenza di placche biancastre, giallastre o grigiastre sulle tonsille suggerisce un’infezione batterica, particolarmente da streptococco, o una mononucleosi, ma non è diagnostica e richiede sempre valutazione medica.
I sintomi soggettivi associati aiutano nella valutazione. Il dolore alla deglutizione è quasi sempre presente, variando da lieve fastidio a dolore intenso che rende difficile inghiottire anche la saliva. La sensazione di gola secca, ruvida o che “gratta” è comune, così come la necessità di schiarirsi frequentemente la voce.
Altri segni includono gonfiore percepibile al tatto delle ghiandole linfatiche sottomandibolari e laterocervicali, raucedine per coinvolgimento laringeo, difficoltà a parlare nei casi più severi, e alitosi quando è presente essudato.
Sintomi associati alla gola arrossata
La gola arrossata raramente si presenta isolata e generalmente è accompagnata da altri sintomi che possono aiutare a identificarne la causa. Il dolore alla deglutizione rappresenta il sintomo più costante, spesso descritto come sensazione di bruciore, pizzicore o come se si inghiottissero “pezzi di vetro” nei casi più severi.
La febbre è comune nelle faringiti infettive, particolarmente in quelle batteriche. La faringotonsillite streptococcica tipicamente causa febbre elevata (>38.5°C), mentre le forme virali possono presentarsi con febbre più moderata o assente. Nei bambini piccoli, la febbre può essere l’unico sintomo evidente.
I sintomi delle vie respiratorie superiori come rinorrea, congestione nasale, starnuti e tosse suggeriscono un’eziologia virale, tipicamente nel contesto di un raffreddore comune. La presenza di tosse è rara nella faringite streptococcica e la sua presenza orienta verso una causa virale.
La raucedine indica coinvolgimento delle corde vocali (laringite) e si verifica quando l’infiammazione si estende alla laringe. La voce diventa rauca, velata o può mancare completamente nei casi più severi (afonia).
Il malessere generale, l’astenia e i dolori muscolari diffusi sono comuni nelle sindromi influenzali e nella mononucleosi. La cefalea accompagna frequentemente le faringiti, particolarmente quelle batteriche.
Sintomi gastrointestinali come nausea, vomito e mal di stomaco possono verificarsi, specialmente nei bambini con faringite streptococcica. L’eruzione cutanea (esantema) suggerisce specifiche infezioni come scarlattina (streptococco) o malattie esantematiche virali.
Differenza tra gola rossa virale e batterica
Distinguere tra un’infezione virale e batterica è importante perché solo quest’ultima richiede terapia antibiotica. Tuttavia, la distinzione clinica non è sempre facile e spesso richiede test specifici.
La faringite virale tende a presentarsi con:
- insorgenza graduale dei sintomi
- febbre assente o moderata
- sintomi respiratori: tosse, rinorrea, congestione nasale
- arrossamento diffuso senza essudati significativi
- linfonodi piccoli
La faringite streptococcica si caratterizza per:
- esordio acuto con febbre elevata (>38.5°C)
- dolore intenso alla deglutizione
- assenza di tosse e rinite
- tonsille molto arrossate con essudato purulento
- petecchie sul palato molle
- linfonodi laterocervicali anteriori ingrossati e dolenti
Il criterio di Centor aiuta a stratificare la probabilità di infezione streptococcica assegnando un punto per ciascuno dei seguenti: febbre, essudato tonsillare, linfonodi anteriori dolenti, assenza di tosse. Un punteggio di 3-4 indica alta probabilità di infezione streptococcica e giustifica il test rapido o la coltura faringea.
Tuttavia, nemmeno i criteri clinici sono completamente affidabili. Il test rapido per streptococco fornisce risultati in pochi minuti con buona specificità ma sensibilità variabile. La coltura faringea rimane il gold standard diagnostico, con risultati disponibili in 24-48 ore.
Durata della gola arrossata
La durata della gola arrossata varia significativamente in base alla causa sottostante. Le faringiti virali, che rappresentano la maggioranza dei casi, tendono ad autorisolversi spontaneamente in 3-7 giorni, con picco sintomatologico nei primi 2-3 giorni seguito da miglioramento graduale.
Il raffreddore comune causa sintomi faringei che durano tipicamente 3-5 giorni, mentre l’influenza può causare mal di gola per 5-7 giorni. La mononucleosi infettiva rappresenta un’eccezione, con sintomi faringei che possono persistere per 2-3 settimane, accompagnati da intensa astenia che può durare settimane o mesi.
La faringite streptococcica non trattata può durare 5-7 giorni, ma il trattamento antibiotico riduce significativamente la durata dei sintomi. La febbre e il dolore faringeo migliorano tipicamente entro 24-48 ore dall’inizio della terapia, anche se è fondamentale completare l’intero ciclo antibiotico per eradicare completamente l’infezione.
Quando la gola arrossata persiste oltre 7-10 giorni nonostante trattamento sintomatico appropriato, è necessaria valutazione medica per escludere cause meno comuni come infezioni da Mycoplasma, mononucleosi, allergie persistenti, reflusso gastroesofageo o, raramente, neoplasie.
Fattori che possono prolungare la durata includono fumo, aria molto secca, scarsa idratazione, continuazione di sforzi vocali, e presenza di condizioni predisponenti come immunosoppressione o diabete.
Rimedi e consigli per la gola arrossata
Il trattamento della gola arrossata di origine virale è principalmente sintomatico, mirando ad alleviare il disagio mentre il sistema immunitario combatte l’infezione. L’idratazione adeguata è fondamentale: bere molti liquidi mantiene la mucosa faringea umida e favorisce la clearance di virus e batteri.
Bevande calde come tè con miele e limone, brodi e tisane possono dare sollievo temporaneo. Il miele ha anche proprietà lenitive e blandamente antibatteriche, ma non deve essere somministrato a bambini sotto un anno per il rischio di botulismo.
I gargarismi con acqua salata tiepida (mezzo cucchiaino di sale in 250 ml di acqua) possono ridurre il gonfiore e il disagio faringeo attraverso l’azione osmotica che riduce l’edema della mucosa. Dovrebbero essere eseguiti 3-4 volte al giorno.
Gli analgesici come paracetamolo o ibuprofene riducono il dolore e la febbre. L’ibuprofene ha anche azione antinfiammatoria che può essere particolarmente utile. Le dosi devono essere appropriate per età e peso, particolarmente nei bambini.
Le pastiglie per la gola contenenti anestetici locali (benzocaina, lidocaina) o antisettici possono fornire sollievo temporaneo. Spray anestetici possono essere utili ma l’effetto è breve. È importante non eccedere nelle dosi consigliate.
L’umidificazione dell’ambiente, specialmente durante la notte, previene l’eccessiva secchezza della mucosa. Gli umidificatori ad aria fredda sono preferibili a quelli a vapore caldo per evitare rischi di ustioni.
Il riposo vocale aiuta quando è presente anche laringite. Evitare di sussurrare, che paradossalmente sforza di più le corde vocali rispetto al parlare normalmente a volume basso.
Evitare irritanti come fumo di sigaretta, aria condizionata diretta, e ambienti molto secchi o polverosi accelera la guarigione. Anche cibi e bevande molto caldi o molto freddi, cibi piccanti o acidi possono aumentare l’irritazione.
Quando consultare il medico
Sebbene la maggior parte delle gole arrossate si risolva spontaneamente, alcune situazioni richiedono valutazione medica. È importante consultare il medico se i sintomi sono particolarmente severi sin dall’inizio, con febbre molto alta (>39°C), dolore intenso che impedisce di deglutire liquidi, o difficoltà respiratorie.
La persistenza dei sintomi oltre 7 giorni senza miglioramento richiede valutazione per escludere infezioni batteriche, mononucleosi o altre cause. Il peggioramento dei sintomi dopo i primi giorni, invece del miglioramento atteso, può indicare una complicanza o una sovrainfezione batterica.
Segni di allarme che richiedono attenzione immediata includono:
- difficoltà a respirare o respiro affannoso
- eccessiva salivazione con impossibilità di deglutire
- rigidità nucale associata a forte cefalea
- eruzione cutanea diffusa
- sintomi di disidratazione (vertigini, confusione)
Nei bambini piccoli, particolare attenzione va posta a segni di disidratazione (riduzione delle lacrime, fontanella infossata, pannolini asciutti per molte ore), letargia marcata, irritabilità inconsolabile, o respiro rumoroso (stridore) che può indicare coinvolgimento laringeo severo.
Pazienti con condizioni mediche predisponenti come diabete, immunosoppressione, malattie cardiache valvolari, o anamnesi di febbre reumatica dovrebbero consultare il medico più precocemente, anche per sintomi apparentemente lievi.
La presenza di sangue nell’espettorato o nella saliva, gonfiore asimmetrico della gola o del collo, o cambiamenti persistenti della voce (oltre 2-3 settimane) richiedono sempre valutazione specialistica per escludere patologie più gravi.
Prevenzione della gola arrossata
La prevenzione della gola arrossata si basa principalmente su misure igieniche e sulla riduzione dell’esposizione a fattori di rischio. Il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi rappresenta la misura preventiva più efficace contro le infezioni respiratorie, riducendo significativamente la trasmissione di virus e batteri.
Evitare il contatto ravvicinato con persone malate riduce il rischio di contagio. Nei periodi di picco influenzale o durante epidemie, limitare la frequentazione di luoghi affollati può essere prudente, specialmente per persone fragili.
Non condividere oggetti personali come bicchieri, posate, bottiglie d’acqua o asciugamani previene la trasmissione di patogeni. Anche evitare di toccarsi bocca, naso e occhi con mani non lavate riduce l’autoinoculazione di virus.
Mantenere un buon stato di salute generale rinforza le difese immunitarie: alimentazione equilibrata ricca di frutta e verdura, sonno adeguato, attività fisica regolare, e gestione dello stress contribuiscono a un sistema immunitario efficiente.
La vaccinazione antinfluenzale annuale riduce il rischio di influenza e delle sue complicanze, inclusa la faringite influenzale. È particolarmente raccomandata per bambini piccoli, anziani, e persone con patologie croniche.
Evitare il fumo di sigaretta e l’esposizione al fumo passivo protegge la mucosa faringea, rendendola meno suscettibile a infezioni e irritazioni. Il fumo danneggia i meccanismi di difesa locali e mantiene uno stato di infiammazione cronica.
Mantenere un’adeguata umidificazione degli ambienti, specialmente durante l’inverno quando il riscaldamento secca l’aria, previene l’irritazione della mucosa. Un’umidità relativa del 40-60% è ottimale.
L’idratazione adeguata mantiene le mucose umide e funzionanti ottimalmente. Bere acqua regolarmente durante la giornata supporta i meccanismi di difesa locali.